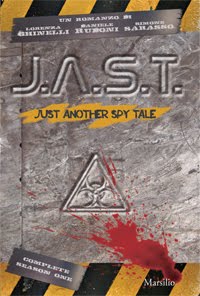Questo pezzo ce l’ho in testa da mesi, e a dirla tutta avrei dovuto scriverlo settimane fa.
Un minuto dopo l’ultimo fotogramma.
Un minuto dopo la fine dell’ultima puntata di Prison Break: il top del serial d’azione in 57 episodi.
Ma in mezzo si son messi il libro nuovo, gli articoli per le riviste, le letture arretrate.
E così è passato più di un mese.
Ora, vediamo se riesco a raccapezzarmi.
L’assunto di fondo è semplice: attualmente, in America, la Teoria della Cospirazione è bifronte.
Due sole produzioni sono riuscite a catalizzare, assorbire e stravolgere il protocollo della paranoia che ha invaso il paese dopo l’11 settembre.
La percezione del real country è ben più che allucinatoria: ha assunto – da sette anni a questa parte – le caratteristiche della sindrome da stress post traumatico.
Shock vigile.
24 e Prison Break sono la cronaca in diretta di quello shock.
Senza volermi addentrare troppo nel confronto delle trame (di 24 parlerò un’altra volta, in questo pezzo m’interessa la grammatica di Prison Break), un dato mi pare degno d’essere registrato.
Dato unificante, che si fa latore di una insperata profondità di campo sul reale: il Presidente degli Stati Uniti d’America, in nessuna delle due serie, assomiglia a quello in carica.
In 24 è il focoso David Palmer: uomo di colore, tutto d’un pezzo, emblema indistruttibile del nuovo sogno americano (l’intramontabile, quello sempre di moda)
In Prison Break è l’algida Caroline Reynolds: bionda, wasp e mica tanto affidabile.
Reynolds: bionda, wasp e mica tanto affidabile.
Un nero e una bionda: Barack e Hillary.
Troppo facile.
Consentito dar di gomito (‘sti americani: guardano il tg e poi scrivono le serie di fantapolitica…), peccato che gli sceneggiatori di 24 si siano inventati Palmer nel 2001, quelli di Prison Break abbiano creato Caroline nel 2004.
Prima di ogni legittimo sospetto sulle candidature democratiche.
E qui la prima caratteristica del nuovo modo di narrare: la visione del futuro.
WM1, nel saggio sul New Italian Epic di cui si discute parecchio in questi giorni, ha segnalato come caratteristica distintiva di una certa produzione letteraria di casa nostra degli ultimi quindici anni un ritorno coraggioso e serio al “massimalismo”. Niente più storie d’ombelichi come si usava nei Novanta, ma grandi temi.
Temi importanti, fondanti: la Storia (quella con la S maiuscola, che è ontologicamente fondante) sopra tutti gli altri.
Credo che serie come 24 e Prison Break abbiano (più o meno consciamente) insegnato parecchio ai Nuovi Epici Italiani.
Prison Break parte dal minuto per abbracciare l’universale, utilizza un microdramma per spalancare i confini del complotto.
Si occupa dell’attuale. Lo prefigura, lo iconizza, lo stravolge.
Si occupa del futuro.
Non dimenticando, nemmeno per un attimo, di mantenere l’attenzione focalizzata sulle storie.
Io, che New Italian Epic mi ci sento parecchio, ho sempre avuto una certa difficoltà a occuparmi di Storia senza farmi sfuggire di mano i personaggi. E volente o nolente, credo che questo sia un problema di molti appartenenti alla categoria.
Mi spiego meglio: troppo preoccupato di raccontare i Fatti (sempre quelli con la F maiuscola) per filo e per segno, mi è sembrato naturale bidimensionalizzare i personaggi.
Il mio è stato un peccato d’imperizia (al quale sto cercando di ovviare in Settanta), ma a ragionarci bene mi pare che qualcosa del genere sia successo a tutti i rappresentanti del NIE citati da Bui nel saggio.
Almeno una volta, dico.
Pensate all’imprenditore Ilio Donatoni di De Cataldo in Nelle mani giuste, a Tito in 54 o al Kissinger di Nel nome di Ishmael di Genna. Psicologie sacrificate al grande intreccio, aderenze al reale che depotenziano il personaggio. Character che perdono qualcosa tentando disperatamente di essere troppo reali.
Agli americani questo succede meno.
Ai protagonisti di Prison Break non succede per niente.
La cifra del reale, la cifra di denunzia, quella più strettamente “controinformativa” è presente.
Ma la psicologia è salva. Gli eroi della serie sono tridimensionali: mutano, evolvono, e, nel caso paradigmatico dei cattivi, finiscono comunque per andarti a genio. Nonostante tutto.
Lo dico da sempre, al mio Sterling è difficile affezionarsi. Difficile sviluppare empatia nei suoi confronti.
A T-Bag, lo spietato pedofilo serial killer del serial di Scheuring, invece, ci si affeziona.
Qualche volta si finisce persino per tifare per lui.
Lo stesso succede con Bellick, la guardia carceraria che, per troppa smania di inchiodare i fratelli fuggiaschi, finisce per passare il limite e si ritrova prigioniero a sua volta.
Bellick è, in buona sostanza, un pezzo di merda. Ma anche alla sua storia ci si attacca. Magari non subito. Magari ti ci vanno due serie e mezza, ma alla fine, ancora una volta, fai il tifo per lui.
Dice: come ci riescono?
Prima di tutto è una questione di tempi.
Ogni stagione di Prison Break (PB d’ora in avanti) dura ventidue puntate.
Ogni puntata è di 42 minuti (secondo più, secondo meno).
Una tale dilazione temporale tramuta il cinema in letteratura.
È la rinascita del feuilleton: dura tridimensionalizzare un personaggio in due ore. Per farlo, nel cinema, occorrono il salto temporale, (flashback o flash forward) o l’elemento drammatico, il colpo di scena, il cambio radicale delle carte in tavola.
Nella serie, i cambiamenti possono essere graduali. Si possono usare le stesse tecniche del cinema (Lost, ad esempio, vive di flashback e flash forward) ma con meno ansia da prestazione.
Il tempo dilata la percezione. In PB lo spazio narrativo allarga le prospettive, trasforma gli amici in nemici, i buoni in cattivi, i nemici in alleati.
La vocazione al cambio di fronte, tipicamente ellroyana, è uno degli altri elementi costituenti del serial.
Eccezion fatta per il protagonista tatuato e per suo fratello (ma per suo fratello occorrerebbe fare un discorso a parte), tutti i personaggi cambiano bandiera. Chi, più svelto, nel giro d’una serie (Il direttore del Fox River, la dottoressa Tancredi), chi nel corso delle tre stagioni (Sucre, il romantico compagnone, diventa più cinico e finisce per mettere gli amici in secondo piano; Alexander Mahone è il classico “cattivo giustificato, lo sbirro che si danna per fare il bene e finisce per mandare tutto a rotoli; persino il boss John Abruzzi dimostra un attaccamento à la Soprano per i suoi figli, e l’elenco potrebbe continuare).
Ancora una volta, si dimostra come il cuore dell’epica rimangano i personaggi, e il turning point è il mutamento del character, la sua rivoluzione interiore, l’eterna domanda che stravolge ed eleva: che cosa sei disposto a fare per andare fino in fondo?
PB, però, spinge il limite ancora più in là. Il dualismo, l’ambivalenza di buio e luce diventano cifra estetica.
Tutti si saranno chiesti come fosse possibile che una serie fondata sulla fuga potesse sopravvivere una volta che i protagonisti riescono a mettere (finalmente) il culo oltre le sbarre.
È proprio qui che gli sceneggiatori hanno dato il meglio.
La prima stagione è fredda. Il Fox River è l’antro della strega, la prigione di Dantes, l’archetipo buio e umido della prigione. Nella season two, il mondo esterno esplode in faccia ai nostri eroi. E l’azione si sposta per le strade, al caldo. Sole ovunque, deserti sconfinati, la fuga si muta nella cifra beat del viaggio.
Coast to coast e oltre. Fino a Panama.
E quando oramai tutti, ma proprio tutti, si sono abituati a vedere i Fox River Eight (che nel frattempo sono sempre meno di eight) in libertà, ecco che Michael, il protagonista, finisce un’altra volta dentro.
Ribaltamenti continui, buio e luce in alternanza ponderata, mai frenetica.
Esasperante.
La sorpresa estrema raggiunge lo spettatore all’abbrivio della terza serie. Per tutta la seconda stagione, la prigione è stata solo un ricordo. Quasi si è perso il core stesso del serial.
Ed ecco che torna in gioco il carcere.
Un carcere talmente estremo da mettere in discussione le più ataviche paure del telespettatore.
Seguitemi bene, perché qui sta il fulcro. L’essenza stessa dell’epica americana old school.
Personalmente, sto con Aristotele, che, nella Poetica, dice semplicemente che Omero non scriveva ditirambi, istituendo una continuità tra epica e potenza tragica. L’epica, in effetti, mi pare un assommarsi di tragedie incollate tra loro secondo un magistrale protocollo narrativo.
L’escalation della tragedia in PB è già massima nella prima stagione: che c’è di peggio di essere rinchiusi (magari innocenti) in gabbia con cristoni grandi, grossi e incazzati, che non vedono l’ora di trasformarti nella loro fidanzatina al primo giro di doccia?
Nulla, avrei risposto. Finché non ho visto la prigione di Sona, vero nucleo narrativo della season three.
Il modo in cui Sona viene presentata allo spettatore è agghiacciante.
Totale assenza di guardie, il posto è troppo tosto. I secondini stanno fuori, coi fucili spianati.
Dentro, la legge la fanno i detenuti.
Il corridoio d’ingresso, incrostato di liquami, rottami umani (Bellick rantola nudo sul pavimento), facce truci e lame.
In cortile, sotto la pioggia, due uomini combattono per la vita.
Uno vince, il cadavere dell’altro rimane sotto al sole per giorni.
Né cibo, né acqua, né igiene sono minimamente garantiti.
Welcome to Sona.
Ho reso l’idea? Al confronto, il Fox River diventa il Plaza.
Dopo lo shock iniziale, tutto riprende secondo canoni narrativi consolidati (qualcuno arriva, qualcuno se ne va, Michael deve scappare; in sottofondo il complotto, la solita vecchia teoria della cospirazione). Ma intanto lo shock c’è stato. D tragedia in tragedia.
Così si fa l’epica.
Massimo rispetto agli sceneggiatori americani. Allo stuolo di artisti sottopagati (e per questo giustamente incazzati e scioperanti da un bel pezzo) che dà il meglio in ogni puntata, in ogni singola stagione.
Il vecchio adagio dei nostri professori incartapecoriti è sempre meno valido di fronte a produzioni come PRISON BREAK: una volta ogni tanto, prima di spegnere la tv e rannicchiarti su un libraccio, dai un’occhiata al palinsesto.
Potresti imparare qualcosa.