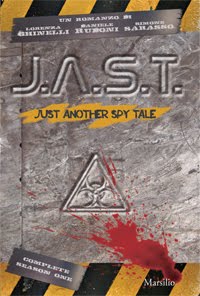Ne ha già parlato Aldo Grasso, lo so. E ci ha scritto pure un ottimo libro.
Libro che non ho (ancora) letto, e quindi mi sento in parte scagionato da possibili “sincronie”.
Ne aveva scritto tempo fa un giornalista del Guardian riguardo ai Sopranos, paragonando l’autore della serie a Dickens e lo show al moderno feuilleton.
E secondo me non aveva torto. Anzi.
Da tempo sono un sostenitore della commistione tra letteratura, cinema, videogames, fumetti e rete. Se ne sarà accorto chi ha dato un’occhiata a Confine e s ne accorgerà (con annesso sobbalzo sulla sedia) chi leggerà le produzioni venture (J.A.S.T. e United We Stand in testa, ma pure Settanta, il seguito di Confine di Stato).
Credo che la letteratura (specie quella italiana) si sia svecchiata parecchio negli ultimi dieci anni e abbia sempre meno paura di strizzare l’occhio ai media mainstream. Un vecchio adagio anni Sessanta riservava il massimo dell’espressione intellettual-rivoluzionaria a ristretti spocchiosi circoli sinistrorsi in cui imberbi Che Guevara si sciroppavano infiniti polpettoni eisenstaniani, lottando per tenere gli occhi aperti ed emozionandosi sinceramente una volta squarciato il velo.
Già nei primi Ottanta l’epilogo della faccenda mostrava il suo vero volto dai fotogrammi del capolavoro di Paolo Villaggio: Fantozzi che urla “La Corazzata Kotiomkin (nel film l’originale Potemkin era stato storpiato per questioni di copyright) E’ UNA CAGATA PAZZESCA!” è un’intera epoca che fa i conti col proprio immaginario.
Paolo Villaggio stesso, amico intimo di De Andrè ed esponente della crème dell’intelligentjia di sinistra della Genova del Sessantotto cambia strada. E si dà al mainstream. Con tutto l’orgoglio e l’ironia di cui quella generazione di geniacci fu capace.
In un’intervista che cito spesso, Jean Jacques Annaud, regista de Il nemico alle porte svela una dei più grossi segreti della nostra epoca in materia di entertainment: qualunque storia popolare, di questi tempi, deve fare i conti coi blockbuster hollywoodiani.
Nello specifico Annaud non si vergogna (e lo dice a chiare lettere all’intervistatore) di usare moderne tecniche di ripresa, effetti speciali e scene d’azione da cardiopalma per raccontare una storia che di yankee non ha nemmeno l’ombra.
La storia è quella di un cecchino russo Vassili Zaitsev durante la battaglia di Stalingrado. Niente di più palloso, potenzialmente. Un’altra Potemkin.
E invece no, perché il cecchino ha la faccia di Jude Law, è cool perché centra i nazi col fucile da sniper, e tutta la storia è costellata di azione, esplosioni, emozioni forti.
Evitando di storcere il naso di fronte al mainstream, Annaud ha raccontato una storia misconosciuta e nodale.
La storia di un eroe comunista a difesa dell’ultimo baluardo di libertà in Europa: Stalingrado.
Questo genere di storia sarebbe stata benissimo nei cineforum di quarant’anni fa. I Guevara della Bassa si sarebbero entusiasmati e avrebbero speculato sul carattere rivoluzionario e antiamericano dell’opera. Avrebbero brindato a Stalin e Krusciov.
Mai e poi mai avrebbero immaginato che di una storia del genere se ne potesse fare una produzione Paramount in grande stile.
In tempi più recenti, il lavoro di Wu Ming ha delle analogie con questo atteggiamento.
Se si pensa a 54, si riconoscerà tra i personaggi Ivan Alexsandrovic Serov, il primo Presidente del KGB.
Immaginatevi che appeal possa avere un personaggio del genere sul lettore medio. Eppure, grazie alla bravura dei narratori, Serov non sfigura di fianco a Cary Grant. E non sembra nemmeno così bidimensionale come Ernst Stavo Blofeld (il capo della Spectre) nei romanzi di Fleming.
E qui ci avviciniamo alle serie tv.
La narrazione popolare ha bisogno di grandi storie. E se le storie che racconta hanno un doppio fondo reale (vedi Annaud, così come i libri del ciclo americano DI Evangelisti), tanto meglio.
Ché la memoria collettiva ha sempre un gran bisogno di essere rinfrescata.
Qualunque storia, però, per essere compresa, deve parlare la lingua del proprio tempo.
Ed è questo il motivo per c ui le serie tv hanno un pubblico maggiore degli sceneggiati RAI.
ui le serie tv hanno un pubblico maggiore degli sceneggiati RAI.
Prendiamo LOST. Milioni di telespettatori in tutto il mondo. Fan che si strappano i capelli e darebbero un braccio per un’anticipazione sulla prossima serie. Geeks de noantri che si scaricano le puntate il giorno dopo che sono uscite in America. E le guardano in inglese, pur di sapere come va a finire.
Perché? Perché non funziona così anche con la nostra fiction su Garibaldi?
E dire che i temi della nostra produzione in camicia rossa sono ben più importanti: il sogno di un Paese, le nostre radici, il miraggio dell’unità. Il sangue e la polvere di quei giorni. Mica roba da poco…
E invece LOST cosa mette sul piatto: temi triti e ritriti. Il Triangolo delle Bermude, l’Isola di Gilligan, la teoria del complotto, una spolveratina di crime novel e di commedia brillante, quattro scopate e un po’ di mistero.
Eppure…
Un miliardo di spettatori da una parte e nemmeno trecentomila dall’altra.
Dove sta il segreto?
Non in quello che si dice, ma in come lo si dice.
Gli sceneggiatori di LOST ci fanno saltare sulla sedia. Ogni puntata apre con un problema apparentemente insolubile e una scena d’azione. Nel corso dell’episodio il problema si risolve, ma prima della fine stai pur certo che se ne presenterà un altro. Un altro così difficile da risolvere che non vedi l’ora che sia ancora mercoledì. Finisci per diventare schiavo della continuity. E tutta la situazione si esaspera ancora di più quando l’episodio è l’ultimo della serie. Perché la voglia ti deve rimanere addosso per sei mesi almeno.
E i personaggi?
Non è più bella la nostra Anita con la faccia della bellissima gossippara di turno in confronto a quella sciacquetta di Kate?
No, signori. Affatto. E non perché le donne di casa nostra siano meno attraenti di quelle d’oltreoceano.
Ma semplicemente perché la Kate di LOST è un personaggio complesso, pieno di rimorso e senza direzione. Che soffre a ogni passo e si vede. In più, aggiungici faccia e corpo da modella e una voce doppiata da un cavallo di razza.
Anita sarà pure bellina, ma come apre bocca viene fuori quel romanaccio glabro delle periferie (che non si addice a una signora cresciuta in Brasile e vissuta a Ravenna). Il suo personaggio è piatto come una tavola da surf, ombra meschina dell’eroe BarbaBionda, e non assomiglia né alla sé stessa dell’Ottocento, né alla telespettatrice dall’altra parte del tubo catodico. Che cosa comunica allo spettatore? Un bel niente, ecco cosa.
Senza contare che i serial di casa nostra, sei puntate e tutti a casa. Quelli americani riescono a tenere la tensione per ventitre, ventiquattro episodi a stagione.
Per cui ecco il punto.
Chi fa il mio mestiere, chi vende storie popolari in cambio di danari, deve aver cura di chi quei danari li spende.
Il lettore non può perdersi dietro alle turbe dell’incomunicabilità dell’autore. Non può sorbirsi personaggi piatti e senza sentimenti. Non può non saltare sulla sedia.
Perché chi se compra una storia nera o un romanzo di spie ha pagato per il pacchetto completo, con tanto di suspence, emozione ed esplosioni.
Quindi, e lo dico prima di tutto a me stesso, chi fa questo mestiere, quando è davanti alla tastiera, dovrebbe portarsi appresso gli insegnamenti degli sceneggiatori del serial d’oltreoceano.
E magari le sue pagine inizierebbero a spirare un’inusitata ventata di freschezza.