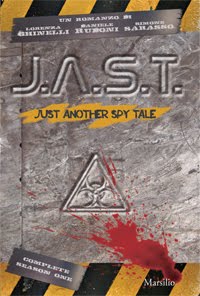(Quasi) ristabilito dal massacro gastrointenstinale, cerco di rimettermi in sesto con pubblicazioni e mail arretrate. Mentre una montagna di corrispondenzainevasa infesta le mie cartelle di Thunderbird mi giunge notizia che è finalmente disponibile (nelle librerie Feltrinelli, su www.milanonera.com o semplicemente cliccando il banner in fondo a destra) il terzo numero del free press MilanoNera.
Su quel numero il vostro scrittore over 100 preferito ha intervistato uno dei suoi maestri: il signore del noir Giuseppe Genna.
Sul giornale cartaceo l'intervista è stata (giustamente) mozzata. In realtà quelle 4000 battute che potete leggere a p.11 non sono che il cuore di una ben più lunga conversazione, che ho il piacere di riproporvi per intero.
Buona lettura.
FACE OFF
Giuseppe Genna e Simone Sarasso
Doveva essere un’intervista. È diventato un faccia a faccia. Mi era stato chiesto d’intervistare l’autore di Hitler, il best seller recentemente uscito per Mondadori. Io sono andato a caccia dell’uomo che mi ha insegnato a scrivere.
Lo dico da una vita: senza i libri di Giuseppe Genna, non avrei mai scritto i miei.
Senza la quadrilogia di Lopez (Catrame, Nel nome di Ishmael, Non toccare la pelle del drago, Grande madre rossa) non mi sarei mai interessato al noir, non avrei mai letto Ellroy, non avrei scoperto un mondo.
Vediamo, dunque, di partire proprio da lì. Da dove tutto è nato.
SS: Giuseppe, da tempo dici di aver abbandonato il noir e il thriller. I tuoi libri sono altro, adesso. La gabbia narrativa del genere è esplosa, è esorbitata, si è espansa. Da L’anno Luce a Hitler c’è un’abisso.
La distanza stilistico-concettuale delle tue ultime creature dalle prime è siderale.
Ti seguo da anni, da anni ti studio e so come è avvenuta quest’ultima evoluzione. Quello che non so, che mi chiedo da sempre, è come tu abbia avuto l’intuizione per scrivere i tuoi primi quattro libri.
Non esisteva niente del genere in Italia, prima. Nessuno faceva controinformazione a quel modo. C’erano in giro parecchi protagonisti “sporchi” e politicamente scorretti, ma nessuno aveva un narratore così cattivo.
Come è nata quella magia?
GG: Detto che per me non è una magia, e che considero la quadrilogia di Lopez sotto lo sguardo di certe poetiche che mi interessano ora, va detto che ad altezza della scrittura di Catrame, almeno in Italia, la tradizione del giallo e del thriller e del noir era considerata e praticata contraddittoriamente. Esisteva poi una situazione che era quella dell’attualità sociale e politica, con una rimozione pressoché assoluta della continuità storica tra certi eventi e svolte di un Paese addormentato. Questo, da un lato.
Dall’altro lato, c’era per me un’evidenza della presa di piede di un protocollo che concerneva un cattivo immaginario, a mio parere automaticamente derivante dalla sottocultura a cui l’Italia si era esposta – e intendo il protocollo della paranoia, estetizzato con suspence sempre più frequentemente utilizzata nella fiction cinematografica e televisiva. Qualcosa che in America era già decaduto e che preludeva a una rinascita del romanzo storico. Dal punto di vista del confronto con la poetica, c’era un problema che per me era devastante, e cioè l’idea critica di “contaminazione” tra i generi, un residuo postmoderno scaduto come si dice che un alimento è scaduto, e i risultati che eiettava spettacolarmente (penso alla stagione dei Cannibali) erano non soltanto scaduti a priori, ma anche letterariamente scadenti (a parte Woobinda di Aldo Nove, che però è poesia, non narrativa). Si trattava di un conato di reviviscenza della Neoavanguardia storica, che a mio parere ha un torto gravissimo nella dialettica che ha imposto in questa sua esasperante sopravvivenza: l’annullamento della narrazione popolare.
Inoltre c’era il problema che sollevi tu: la necessità che la controinformazione non paranoide, ma basata su studi documentali, si trasformasse in materia di narrazione storica, e venisse metabolizzata dalla letteratura.
In tutto ciò, lo sfondo critico, che ai tempi era pesante e adesso, nel giro di un decennio, si è ridotto all’altezza che merita. L’Italia soffre di nanismo critico, di un’attenzione viscerale e ciecamente specialistica alla propria tradizione, intesa soprattutto come lingua di superficie e in particolare come sguardo sullo stile, di derivazione continiana. Perfino in poesia, l’erede di questo approccio stilistico, cioè Mengaldo, nella sua antologia poetica del Novecento italiano esclude Cesare Pavese, e si capisce perché – è il poeta che utilizza un ritmo che cerca di sfondare il petrarchismo e apre alla narrazione, diventando popolare (Verrà la morte e avrà i tuoi occhi è il libro di poesia italiana più acquistato e letto degli ultimi trent’anni di editoria di settore e Pavese è uno dei pochi italiani moderni tradotti ovunque all’estero). Questo, il quadro.
Per quanto concerne la scrittura del mio primo noir, si è trattato di una casualità. Mio padre amava svisceratamente Maigret, aveva letto Simenon (anche i romanzi non di genere) più volte, e io volevo fargli un regalo: un piccolo giallo senza pretese che aggiornasse la figura di Maigret e la collocasse nella zona in cui sono cresciuto e mio padre viveva a quei tempi. Avendo studiato i 19 (19...) volumi degli Atti della Commissione Parlamentare sulla P2, privi di indice analitico e sigillati dall’”eroica” Tina Anselmi con una relazione di 36 (36...) pagine, disponevo di una visione circa il ruolo non solo di Gelli, ma delle radici che Gelli ha incarnato nel Dopoguerra italiano. Si tratta di una scansione della nostra storia che coincide con quella della “sovranità limitata” fornita dal giudice Salvini nella sua accusa sui fatti di Piazza Fontana. E’ una visione che differisce dallo scontro semplicistico tra estrema destra, estrema sinistra e apparati dello Stato, con influenza della Cia e di altri organismi. Viene alla luce il ruolo di certe tecnocrazie, embricate in Italia, la nazione chiave per comprendere la Guerra Fredda. A questo si aggiunga l’inesausta aggressione inglese al Vaticano e, dunque, all’Italia stessa, a partire dall’immediato Dopoguerra, quando il nostro Paese non disponeva di servizi segreti propri, sostituiti da quelli inglesi (De Lutiis, eccelso storico della materia, è molto preciso su questo punto). In Catrame non esiste davvero un’influenza letteraria esterna. Ellroy mi ha piegato polso e immaginario successivamente, quando c’è stato da affrontare il caso Mattei, inserendolo in una continuità che conduce al nostro presente. In quegli anni cresceva un fronte narrativo anti-postmoderno, di cui i frutti sono assai visibili oggi. Faccio il nome di Evangelisti e Wu Ming su tutti, perché è grazie a loro che l’idea stessa dei sottogeneri (il genere è il romanzo: non esistono romanzi di genere) è saltata, verso la conquista di un’affabulazione allegorica, che reinstalla l’idea di un’etica interna alla scrittura. Il bilancio, che è però anche una profezia, è fatto nel saggio di Wu Ming 1 sul New Italian Epic.
SS: Se nella concezione della mia trilogia ho immaginato uno scenario occulto per il paese degli ultimi cinquant’anni, lo devo a te. Alcune delle intuizioni fondamentali dei miei romanzi sono rielaborazioni di suggestioni che tu hai disseminato nei tuoi.
Una su tutte, su cui si basa l’architettura intera della mia opera: la presenza sul suolo italico di un’organizzazione (militare e di intelligence) col compito di intervenire (anche militarmente) in caso di pericolo rosso (il che significa anche in caso di vittoria democratica delle sinistre).
La mia Ultor è in un certo senso la trasfigurazione della tua Ishmael, ed entrambe sono belle copie di Gladio.
Entrambi abbiamo studiato gli stessi documenti, ma è come se tu fossi riuscito, nei tuoi libri, a prevedere degli assetti geopolitici che si sarebbero configurati solo dieci anni dopo (penso allo strapotere cinese di cui parli nel Drago o alle strutture “federali” di intelligence a livello europeo di Grande madre rossa). Da dove viene tanta lungimiranza? Come fai a vedere così lontano? C’entrano i tuoi contatti coi Servizi ai tempi dell’esperienza di consulente alla Camera? E, questione che mi pare ancora più nodale in termini letterari: come si trasforma il nudo dato storico (politico, economico, militare) in letteratura di gran classe?
Fino a che punto è lecito forzare il reale a fini narrativi?
GG: Comincio dall’ultima domanda, che per me è decisiva in termini poetici e non soltanto. Ho una posizione personale, in merito, che desidererei fosse chiara: non è apodittica e non intende proporsi come una verità estensibile ad altri che a me.
A mio parere la realtà è allucinatoria. La realtà è sempre percepita e la percezione è, per ogni branca della neuroscienza, un meccanismo allucinatorio apparentemente stabile e coerente, ma in realtà discontinuo. In questo senso, non guardo all’epos, ma a più che l’epos: guardo alla costituzione psichica totale dell’umano. Mi allineo a una tradizione che nella modernità va da Walser a Kafka a Eliot e Celan, passando per Stevens, e culminando con Burroughs. E’ dalla meditazione sulla struttura allucinogena della percezione di realtà che io desumo la possibilità – anzi, per mio conto, la necessità – di allargare il dato allucinatorio, esaltando la discontinuità. Di qui: allegorie che puntano al “fuori” dello stampo umano, ucronie, discronie, visioni da stress post-traumatico che nascondono traumi dietro altri traumi. Il problema è rendere tutto ciò in narrazione che sia leggibile e popolare.
Non è che io abbia una sfera in cui guardi e preveda il futuro. La geopolitica è una disciplina che studio intensamente e si tratta di una scienza molto dinamica, strapiena di variabili, le cui linee generali però si muovono con modalità abbastanza chiare e incontestabili. Quando scrissi Ishmael, l’editore mi chiese perché, anziché Berlino, ambientassi parte della storia ad Amburgo. Poco dopo accaddero i fatti dell’11 settembre e le indagini su Mohammed Atta condussero ad Amburgo.
Se certe cose non si studiano, non si sanno.
Esistono intercettazioni telefoniche di Atta dall’Afghanistan, pubblicate ai tempi su “Panorama”, in cui Atta si lamenta dell’intrusione massiva di questi “ingegneri cinesi”. Tra l’altro, bisogna dire che anticipare in questo modo alcuni movimenti della realtà conduce sicuramente a un insuccesso editoriale.
Penso a due elementi: la scena dei cinesi cadaveri nel container freezer che apre Gomorra di Saviano sta nel mio Drago; Rampini di altro non scrive che di cose che stanno tutte in quel thriller. Non lo sottolineo per narcisismo, dico solo che ci sono momenti in cui certe cose hanno ricezione; se anticipi troppo non puoi poi lamentarti del fatto che queste cose penetrino a stento in ottomila lettori. Si tratta, però, di un elemento secondario, perché è la narrazione di storie aperte che per me è fondamentale.
Quanto a Ultor, trovo una differenza fondamentale con Ishmael.
Ishmael è un nome che evoca un elemento metafisico, oltreché biblico e coranico, quindi religioso. Ishmael osserva e rimanda all’incombere del bianco accecante della balena di Melville, quella tinta che, citando da Agostino, nel capitolo 42 di Moby Dick è definita “cosmetico spirituale”. Per me il movimento di intelligence, che è una costante storica umana in quanto lo è quintessenzialmente di quella potenza extraumana che si incarna nelle strutture di potere (questa lettura è di Burroughs, non mia), è sempre un movimento metafisico: è la scimmia di Dio, che crede in un Dio inesistente e lo imita, proiettandolo. In Assalto tentavo di accostare l’ordine del Cristo ai suoi apostoli al mandato centrale di ogni intelligence. Non si tratta di controllo mentale, sociale e politico: è l’accesso alla pratica metafisica che viene interdetto, in nome di una conquista religiosa – e non è detto che la religione sappia indurre a pratiche metafisiche, come dimostra il cattolicesimo moderno e contemporaneo.
SS: La punta di diamante della tua narrativa credo che sia la transmedialità. Quello che alla prima lettura di Ishmael mi colpì fu la commistione di linguaggi e di suggestioni. Lopez parla come un divo di Hollywood, vive in una Milano nera peggio di Liberty City, indaga senza scrupoli come Kemper Boyd. Eppure guarda le architetture come lo farebbe Renzo Piano. Il narratore che lo accompagna trascende il linguaggio da strada per esprimere lirismi à la De Lillo, ripiomba nelle più crude bassezze ellroyane e discerta di equilibri planetari come il compianto Sbancor.
Ancora una volta (per quanto il quesito sia banale), come ci riesci? In secundis, qual è la valenza narrativa di questo maelstrom di punti di vista? È necessario forzare la gabbia del genere per “andare fino in fondo”?
GG: Tu, in Confine di Stato hai forzato la gabbia fino in fondo. Il problema sta a monte: esiste una gabbia? Per me no. I generi sono metriche e retoriche che si sono cristallizzate in prosodie prevedibili e in stilemi svuotati psichicamente. Il problema centrale è l’affabulazione. Direi che tutto ciò che dici è riassumibile in questo movimento: Lopez non è un personaggio psichicamente coerente. Ma è proprio l’idea che la psiche e la psicologia siano un dato definitivo, idea primonovecentesca ed eminentemente borghese, ciò che io vedo come avversario poetico. La poetica di Piperno, per esempio, è tutta intrisa di questa convinzione laicista, ma per me non radicale e non all’altezza di quanto un intellettuale deve fare nel momento in cui è immerso nel tempo e cerca di scardinarlo. Sono poetiche differenti, ognuna con piena legittimità di esistenza. Il successo della poetica neoborghese, quella alla Piperno, è spiegabile attraverso un meccanismo di identificazione e di mimesi in scala 1:1. Io non cerco quella mimesi e non cerco quell’identificazione: cerco un’identificazione altra. Se la letteratura scatta, e questo lo determina esclusivamente il tempo, l’identificazione avviene con qualunque visione, poiché accade istantaneamente nella percezione della fabula.
Sarei curioso di conoscere la tua opinione. Per come tratti i personaggi, la psicologia ha un ruolo molto importante per te, eppure esiste una totale diffrazione che è data dagli eventi e dalle strutture mobili che metti in campo. La tua rappresentazione letteraria è per me un’osmosi di interiorità sbilanciata dall’esterno. Così stabilisci una continuità discontinua tra personaggio e mondo, tra storia e mito. Tu come la vedi?
SS: Per quanto mi riguarda, occorre fare dei distinguo. Tra quello che ho scritto in principio (Confine di Stato), quello che ho scritto dopo (United We Stand) e quello che sto scrivendo ora (Settanta, il seguito di CDS).
Inerentemente a CDS, credo che tu ci abbia preso. I personaggi sono psicologicamente caratterizzati ma estremizzati nella loro eccessiva bidimensionalità. Ecco perché gli eventi (le strutture mobili di cui dici tu) li mettono così a dura prova. La mimesi non è completa. Quello che voglio è raccontare una storia, fare controinformazione. Per farlo uso marionette pavloviane, Big Jim senz’anima, a scatto fisso. Sono tutti dei duri, a parte Trama che è il weird. Ma, seppur weird, agisce come una marionetta (esattamente come gli altri).
Mi interessa l’impatto dinamico della storia contro la massa statica dei personaggi bidimensionali.
Questo perché, io, un po’ le gabbie me le sento addosso.
Con una gran voglia di sventrarle, beninteso. E allora in un romanzo è cosa buona e giusta far agire i personaggi in maniera fumettistica.
Simile e inverso di segno è il discorso per UWS. Proprio perché si tratta di fumetto, il suo ancoramento al reale deve essere mostruoso, fuori misura. Iperrealismo visivo (immagini quasi fotografiche), personaggi ultra caratterizzati (nessuno assomiglia a nessuno) e secondo livello mediatico (il sito, con i vari racconti tangenziali, i giornali fake che informano sull’andamento del mondo sotto minaccia nucleare, le voci in presa diretta dei sopravvissuti all’assedio) per rendere la faccenda il meno fumettistica possibile.
Anche qui, una gabbia che salta. E i personaggi (anche qui pavloviani, anche se “inversamente pavloviani”, rispetto all’accezione di cui si diceva prima) che agiscono di conseguenza.
Differente la prospettiva per Settanta. Qui il punto di vista cambia. Il mondo reale non è più così reale. Il narratore affabula, inventa, crea (finalmente) un universo, che non è più così simile a quello in cui viviamo o abbiamo vissuto.
E i personaggi in quell’universo maturano, evolvono, mutano, si caratterizzano. Finalmente liberati dal riflesso pavloviano. Credo che Settanta segnerà un’evoluzione stilistica nel mio lavoro.
GG: Ecco, questa consapevolezza che sembra calcolare e invece non calcola affatto, ma realizza mentre crea la forma, mi pare un elemento distintivo di chiunque sia emerso da quei sottogeneri del romanzo che sono thriller, noir, fantascienza (includerei anche il “rosa”, che è una mia vecchia tentazione provare a sperimentare). Qui mi occorre farti una domanda, che pertiene l’intimo del momento letterario. Io sono assai spaventato dall’idea che le poetiche, le intenzioni, si mangino l’esito testuale. Sono certamente convinto che in ogni caso un’eccedenza del testo ci sarà, ma ravvedo in tanta narrativa di oggi questa tentazione algebrica, che in parte è dovuta a un sindrome di controllo interno da parte dello scrittore e in parte è dovuta a un cedimento davanti a supposte richieste di mercato della fabula. E’ ironico che, scrivendo di strutture di controllo politico o super-politico, mi pare che entrambi abbiamo anzitutto da superare un controllo interno. E, per quanto ironico, c’è il fatto che nei tuoi libri la materia sostanziale, quintessenziale è il mistero. C’è una frizione tra la sostanza ubiquitaria, che è mistero, e qualunque paradigma di controllo emerga: questo, secondo me, sia nel romanzo sia nel fumetto, crea l’affabulazione che è la tua cifra. Tu avverti questi “confini di stato”?
SS: Sicuramente so che storie voglio raccontare, e qui i casi sono due.
O parlo del passato, dove l’abbrivio è dato dal “nudo fatto” e solo successivamente entrano in gioco caratterizzazioni, distorsioni e interpretazioni volte ad affabulare.
O immagino il futuro, e qui la sponda documentale è ovviamente inesistente. Dunque uso il cinema apocalittico paranoide (l’antesignano di quello che citavi tu prima, che ha negli anni Ottanta di War Games, Alba Rossa e Sindrome cinese la sua età dell’oro) per rendere l’affabulazione sostenibile da un punto di vista narrativo.
In entrambi i casi non c’è il vantaggio della pagina bianca. L’appoggiare le proprie costruzioni narrative su qualcosa d’altro mette in gioco quel paradigma del controllo a cui fai riferimento.
In molta letteratura italiana contemporanea la preoccupazione per il suddetto paradigma è eccessivamente presente. E talvolta gli esiti narrativi dei “preoccupati” sono rigidi, i prodotti “forzati”, poco leggibili. Il rischio di rimanere impigliati nella rete dell’eccessiva coerenza c’è.
Tuttavia, più s’impara il mestiere, più è naturale sentir meno il peso del “materiale d’appoggio”.
Pensa ad esempio a Stella del mattino di Wu Ming 4 o al tuo Hitler. L’ancora documentale è leggera e sfuggente, al punto che siamo ancora qui a discutere se Hitler possa o non possa definirsi romanzo.
Se s’impara bene a gestire la cosa (tu e i Ming avete imparato da un pezzo, io ci sto ancora lavorando), i generi smettono di essere un problema e l’affabulazione (anche quella che ruota vorticosamente intorno al “mistero”) è scorrevole.
GG: Da questa prospettiva che enunci, e che io condivido pienamente, si apre la possibilità di una indifferenza di fondo nella trattazione di passato e futuro, poiché automaticamente convergono sul presente. Questa possibilità è data dall’allegoria. Il fatto di appoggiarsi a “qualcos’altro”, come dici tu, apre a retoriche di distorsione a partire proprio dall’elemento di appoggio. Se questo è posto nel passato, si distorce per far rimbalzare la visione su presente e futuro; se l’appoggio è collocato nel futuro, immediatamente ha un effetto retroattivo e raggiunge, come un arco voltaico elettrico, il nostro tempo e radici antiche del nostro tempo. E’ il concetto di romanzo metastorico che Wu Ming 1 ha fenomenologizzato nel suo saggio sul New Italian Epic: in realtà il romanzo è sempre talmente storico, che è metastorico, altrimenti sarebbe un saggio di passatistica o un trattato di futuristica. E’ la finzione allegorica a creare l’elemento metastorico: il fatto che il racconto significhi altro oltre l’immagine e la storia raccontate...
SS: A proposito del New Italian Epic (si veda, in merito, il saggio di WM1, recentemente presentato su Repubblica e scaricabile da www.carmillaonline.com): Roberto (Bui, a.k.a WM1) ha iscritto Grande Madre Rossa a pieno titolo nel filone di cui ha delineato le caratteristiche nel suo saggio. Io credo che ci abbia preso in pieno. Ma credo anche che le tue ultime produzioni (Hitler in testa) siano altrettanto includibili nella categorizzazione. Che ne pensi? Quali sono state le derive più meramente epiche del tuo lavoro e come hanno influenzato la tua produzione?
GG: Posso dire questo: il testo ha un’eccedenza rispetto alle intenzioni. Se WM1 ravvede in quell’incipit il movimento che descrive, riunisce l’esito letterario alle mie intenzioni: io intendevo fare proprio quella cosa che in New Italian Epic viene così filologicamente fenomenologizzata.
Hitler in sé è un romanzo che non lo è. Lì io tento una cosa che davvero non so se mi è riuscita: le critiche arrivatemi addosso, gli argomenti utilizzati per dire che il libro fa schifo tenderebbero a confermare che l’operazione è riuscita. Ma lo dirà il tempo. In questo caso, io adotto definitivamente la radice metafisica come nucleo sorgivo di un epos possibile: il mito storico e immaginario di Hitler crolla se e solo se si sa e si sperimenta l’elemento metafisico, che è semplicemente la sensazione concreta di essere presenti mentre una cosa accade. Questa sensazione non è allucinatoria: è essa che vede la percezione, la quale è instabile. L’elemento metafisico esige certe retoriche: la tragedia non poteva utilizzare altra lingua, altra struttura, per esaltare l’implicito che non ha linguaggio. Queste retoriche sono abbandonate dalla modernità. Tale abbandono pone per me un quesito fondamentale: l’abbandono avviene col romanzo, che quindi è adatto a incarnare la potenza tragica? Sto con Aristotele, che, nella Poetica, dice semplicemente che Omero non scriveva ditirambi, istituendo una continuità tra epica e potenza tragica (e, in effetti, l’epica mi pare un assommarsi di tragedie incollate tra loro secondo un magistrale protocollo narrativo)? La tragedia si fonda su un vuoto, per quanto concerne me – quel vuoto non si può dire, ma vi si può infinitamente alludere. L’infinità delle allusioni a quel vuoto, che non è soltanto umano, ma non rappresenta alcuna forma superumana o extraumana, è direttamente l’infinità delle storie.
Su questo punto vorrei interrogarti. Tu fornisci una fortissima transmedialità (non nel senso da te conferito prima all’interno di un romanzo) alle storie che scrivi: trapassi dalla letteratura al fumetto al video al fotoromanzo. Quale filo tiene assieme tutte queste manifestazioni rappresentative? E’ la storia? Di cosa è fatta la storia raccontata, e quindi prima immaginata, per te? E’ una questione che mi affascina, perché il tuo lavoro esplode mantenendosi compatto, è coerente pur deflagrando e mi chiedo come fai, quale sia l’elemento subliminale che tiene tutto assieme...
SS: Credo che alla base di tutto, ancora una volta, stiano i personaggi. Sterling è assoluto, transgenerazionale, ultraversatile. Difficilmente me ne libererò. Più facilmente lo riciclerò all’infinito, tritandolo in plurime versioni, stravolgendolo, reinventandolo. Esattamente come si fa coi comics d’oltreoceano da un sacco di tempo (qui in Italia no. Tutti i Bonelli sono cloni di Tex. E l’immobilismo li affligge come un cancro).
Allo stesso modo, sulla strada, ho trovato altri personaggi. Il più delle volte elaborati sullo schema di personaggi storici (vedi il mio Ettore Brivido, così simile al duro della Comasina), altre volte nati per caso (il gangster paffuto che interpreto in Ruby Soho, il fotoromanzo attualmente in produzione, è nato per caso, anni fa, a una festa in maschera. Da semplice feticcio volto a farsi quattro risate, ha preso corpo).
Il medium non è così importante. Sono importanti le storie e ancor di più i character. Questo, credo, dà la compattezza che dici al mio lavoro. Più ancora della Storia o delle storie.
GG: Metti in luce una lingua sotto la lingua, in realtà: è la lingua di un incantamento, che ovviamente esige forme, immagini, sagome per concretizzarsi. I movimenti del personaggio, leggendoti, mi sembrano ancora più importanti del personaggio, e lo sfondo in cui si possono percepire questi movimenti, ancora di più. Credo che la tendenza alla centratura sul personaggio, per come la pratichi tu, cioè scardinando la psicologia, utilizzando la bidimensionalità o lo stridio tra registri e piattaforme, preluda ad abnormi e inaspettati mutazioni della tua scrittura...
SS: Credo che queste righe siano l’analisi più efficace del mio lavoro da quando l’ho iniziato. Hai colto nel segno: sono più interessato ai fatti che hai personaggi, ma è proprio questo estremo interesse all’andamento delle cose che me li fa caratterizzare in maniera così particolareggiata nel nuovo romanzo.
Sperimentando la bidimensionalità dei character in Confine di Stato ho capito di avere in mano un medium insufficiente per raccontare veramente le storie che voglio.
Entrare nella testa del personaggio (meglio se storico), stravolgerlo, presupporne la psicologia, metterlo in moto secondo dinamiche estremamente plausibili, permette alla materia documentale di esorbitare. La narrazione non assomiglia più alla nuda cronaca, si compie in parte quella partecipazione diretta di cui hai detto a proposito di Hitler, si catapulta il lettore in mezzo agli eventi.
Così vorrei che fosse Settanta. La strada per arrivare a tali esiti passa sicuramente attraverso i personaggi e la lingua (specialmente quella parlata dai personaggi stessi). È lì che sto lavorando duramente. È lì che sto modificando il mio modo di narrare.
SS: Voglio chiudere con un quesito speculare a quello con cui abbiamo aperto questa chiacchierata. Il tuo abbandono del noir è ormai conclamato. Con grande rammarico dei tuoi lettori, io in testa.
Per mantenere accesa la speranza, tuttavia, mi chiedo se questa defezione includa definitivamente anche Guido Lopez, il protagonista dei tuoi libri che amo di più.
Mi chiedo se mai tornerà (mutato e stravolto, perché no? In ottemperanza a quella “reversibilità” dei personaggi che propugno a spada tratta in ciò che scrivo, per esempio) in qualcosa di tuo. E se mai tornerai a occuparti di intelligence come facevi un tempo (già nel Dies Irae la prospettiva non era più la stessa, ne converrai) Spero proprio di sì. Noi lettori sentiamo una gran mancanza di quelle parole.
GG: Hai sicuramente intercettato l’obbiettivo del mio lavoro a venire. Io mi sposterò sul futuro. Non so quando e dove mi sarà concesso dal punto di vista editoriale, ma ciò che intendo fare è prendere il futuro immediato, cercare l’allegoria che mette in stato allegorico anche il passato e soprattutto il nostro presente. Ho da anni in testa una trilogia particolare. Qui è previsto il ritorno di Lopez, in forma di una reincarnazione passata di uno dei personaggi. Già oggi esiste una continuità di Lopez: in realtà Lopez c’è in Dies Irae, anche se non si capisce che è lui.
Perché io ho smesso di scrivere thriller con Lopez protagonista? Per stanchezza, anzitutto. Perfino l’assenza di psicologia è psicologica. E’ un meccanismo che, con una profondità abissale, Pasolini mette sotto fuoco in Petrolio, nella scena del “Pratone della Casilina”: venti e passa pagine dove il protagonista, diventato donna, soddisfa oralmente giovani borgatari. Una ripetizione che varia nelle figurazioni, ma angosciantissima in quanto lugubre e profetica della serialità. Io non tollero la serialità. Per cui, detto che esiste un inedito che ha Lopez come protagonista (non so se e quando e quali editori lo stamperanno), io sogno l’annullamento di Lopez così come sogno l’annullamento non del noir o del thriller, ma del mio noir, del mio thriller.
Oggi occuparsi di intelligence nella narrazione è controproducente. Esiste una vastissima letteratura saggistica, sdoganata e fiorita a partire dall’11 settembre. Non funziona più l’allegorema, utilizzando l’intelligence. Poiché la situazione si è spostata: si è spostata nel futuro. La situazione geopolitica per molti anni, a meno che non intervenga il collasso climatico che stiamo imponendo al pianeta, sarà questa: tentativo dell’Occidente di conquistare la cosiddetta “corona” di Paesi ai confini della Cina; mossa sul mercato da parte dei Cinesi; variabile russa che l’Occidente tenterà di conquistare alla sua causa; petrolio contro grano e riso, quale risposta della Corona inglese che non dispone del controllo della produzione petrolifera e reagisce con movimenti speculativi grazie al controllo sul cartello agroalimentare; tentativo di sistemazione del Medio Oriente, soprattutto facendo leva sulla Turchia, che sta per tagliare le risorse idriche che giungono a Israele; tentativo di creazione di un grande Stato dato alla Umma, al radicalismo islamico; definitivo attacco dell’Occidente, mosso da Londra, al cattolicesimo, che già da ora è finito, si è protestantizzato. Ora, i riflessi in Italia delle operazioni di intelligence che ci attendono sono marginali, periferici. Sicuramente non permettono l’allegoria. Che, dico, si sposta più avanti – in un altro genere letterario che, per l’appunto, mi interessa molto. Quando dico che la geopolitica si farà altrove, intendo proprio un altrove che non sta qui.
Perciò quanto devo fare è collocare l’allegoria in uno spazio fisico per significare una tensione al percorso metafisico, che nulla ha a che vedere con la religione. Il futuro, per me, è Kubrick. Spero che i lettori accettino lo scambio.
mercoledì 10 settembre 2008
Iscriviti a:
Commenti (Atom)