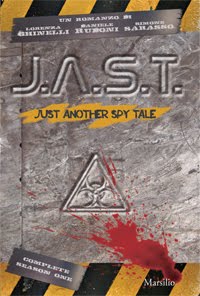Questo pezzo è da ascrivere alla collezione dell’esilio, ossia al periodo del passaggio da Cheapnet a Fastweb.
Io scrivo ora, in questo limbo d’incomunicabilità, e voi leggete che sono già passati un sacco di giorni (quanti? Non ne ho idea. La signorina di Fastweb insiste a dirmi che un tecnico, prima o poi, mi chiamerà. Intanto io invecchio…).
Insomma, si perde un po’ l’immediatezza che rende il blog lo strumento privilegiato dell’instant communication, ma ci sono cose su cui vale la pena di riflettere nel momento preciso in cui ti arrivano all’orecchio.
Molti di voi sanno che, per campare, non faccio solo il professional writer, come c’è scritto in alto a destra nel box di bio. Il terzo stipendio di casa Sarasso (il secondo lo porta a casa da mia moglie, non allarmatevi. La gatta la lasciamo poltrire nella sua pasciuta innocenza) proviene dall’insegnamento.
Cinque giorni a settimana, più o meno quattro ore al giorno, lavoro in una scuola dell’infanzia come insegnante di sostegno.
A dirla tutta non sono un vero insegnante di sostegno, sono un educatore part-time affiancato dal comune all’insegnante di sostegno in ruolo.
E se proprio vogliamo essere precisi, non sono nemmeno un parastatale puro, nel senso che lavoro per una cooperativa a cui il comune ha appaltato il servizio.
In pratica faccio parte, insieme agli operatori di call center e ai clienti fissi delle agenzie interinali (operai, autisti di pullman, impiegati, ecc.) del nuovo proletariato urbano.
Condizione proletaria dalla quale non mi strappa nemmeno la letteratura. È un delizioso aiuto ad arrivare a fine mese, ma per carità non immaginatevi anticipi milionari o vagonate di diritti d’autore.
Questo per amor di precisione e come doverosa premessa al discorso sull’integrazione sociale che sto per tirare fuori.
Siccome in questa casa di scuole se ne frequentano parecchie, tra me e mia moglie (insegnante pure lei), capita talvolta di sentire frasi da scompisciarsi.
Roba che va ben oltre l’allievo non proprio attentissimo all’ortografia che invece di “in bocca al lupo” ti scrive “imbocca al lupo”, dialettale invito alla prova di coraggio suprema, l’impavido nutrire la feria delle fiere introducendole il cibo nelle fauci a mani nude; o l’allieva distratta, che riconosce l’espressione “Nel Paleolitico” come complemento di luogo. E giù a fantasticare di questo regno meraviglioso, popolato di dinosauri e pietre antiche, metà Therabithia e metà Jurassic Park.
Le cose più divertenti, di solito, capita di sentirle in bocca ai genitori, piuttosto che ai figli.
Tipo quella madre magrebina, orgogliosa per i risultati eccelsi del pargolo nella scuola di quartiere (quartiere a maggioranza immigrata: trenta per cento di studenti extracomunitari), ma sinceramente preoccupata per la progressione del suo apprendimento. Al punto da chiedere alla direttrice di spostarlo in un’altra sezione: “Sa, con tutti quei marocchini che ha in classe, la maestra è costretta ad andare a rilento. E finisce che il mio rimane indietro per colpa di quelli là…”
O quel padre, meridionale e da poco trasferitosi al nord, che implorò la dirigente scolastica di eliminare dalla mensa quel piatto etnico “che tanto non ci piace ai bambini, lo avanzano sempre”: la polenta.
Ora, anch’io preferisco il satizzo alla bagna cauda, ma non ne ho mai fatto una questione di Stato. E soprattutto non mi è mai passato per la testa che il bollito monferrino o il tapulòn fossero un patrimonio culturale da salvaguardare e che gli abitanti di Canelli fossero un’antica tribù dedita al culto del Dio Prosecco.
È anche vero che per sentir baggianate non serve andare a scuola.
A mia madre, che vive ancora nel quartiere popolare dove sono nato, è capitata una situazione da Helzapoppin’. Il quartiere in questione, tra i Sessanta e gli Ottanta, era abitato per la maggiorparte da meridionali. Piemontesi pochi (mio padre spiccava per il suo accento esotico) e qualche veneto (ancora più inviso dei meridionali alla massa benpensante biugia nèn), impiegato per lo più nell’edilizia (mio nonno, guarda caso).
Nei cortili dove giocavo da bambino si faceva la salsa, non la polenta. E dalle nostre parti si mangiava la miglior pastiera della città.
Negli anni il quartiere è cambiato, i meridionali sono andati in pensione e i loro figli hanno studiato e perso l’accento dei padri. Intere famiglie si sono trasferite dalla periferia al centro. Nessuno dei miei compagni di scuola abita più nel quartiere.
Quelle case popolari, vuote, non hanno dovuto aspettare molto per trovare nuovi inquilini. La prima ondata magrebina arrivò all’inizio dei Novanta. Poi fu il turno della grande immigrazione marocchina e di quella albanese. Morale della favola: mia madre (che non s’è mai sognata di spostarsi di cento metri) abita tra una famiglia albanese e una marocchina, e cucina un couscous montone e peperoni che levati.
La situazione da Helzapoppin’ è di qualche settimana fa, quando mammà ha chiamato un paio di ragazzi del quartiere per farsi dare una mano a spostare dei mobili (noi figli degeneri oziavamo al sole greco).
Hamed (chiameremo così per convenienza il suo vicino) si è affrettato a suonarle il campanello con gli occhi fuori dalle orbite: “Nadia, tutto bene? Sai, ho visto due marocchini in cortile che trafficavano con la tua roba…” Testuali parole.
Giorni fa, un signore alla tv ringraziava l’immigrazione extracomunitaria perché, da quando c’erano gli albanesi, lui aveva smesso di sentirsi dare del terrone.
In quartieri come il mio (ennesimo inciso: ho cambiato città, ma la fissa del proletariato hard-core m’è rimasta addosso. Mentre scrivo, il signor Kocirai è appena rientrato col furgone e la techno a palla, e Carmine e Domenico cantano ancora popopopopopò con la maglia azzurra indosso) l’integrazione era roba per i nostri vecchi. E c’era chi non aveva problemi e chi la risolveva a coltellate.
Noi ragazzini, ad ogni modo, si andava a scuola insieme e il pallone era lo stesso per tutti, pure se in casa non si parlavano italiano (mia nonna, from Scardovari, Italy, non lo parla ancora adesso).
E se butto l’occhio nel cortile della mia scuola e vedo Gaetano, Bai-Xiao e Micheal (Gaetano è di colore, Micheal è appena tornato dal mare di Posillipo e Bai-Xiao dice solo “ciao”. È arrivata da Canton da venti giorni e vive con la zia) che litigano per la palla e poi si mettono a disegnare con gli stessi colori, penso che c’è ancora speranza per questo paese malandato.
Nonostante le polente etniche e i marocchini che si cambierebbero il cognome in Brambilla, se potessero.
Serve tempo, mi dico. Servono anni, generazioni. E se continueremo a non dimenticarci la lezione di Gaetano, Bai-Xiao e Micheal, magari ce li ritroveremo in Nazionale o in Parlamento senza troppi drammi. Alla guida di una paese, grazie a Dio, molto diverso da quello dei nostri nonni.