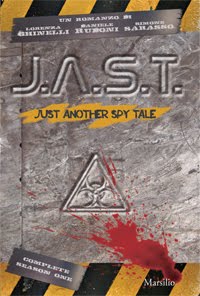In questi ultimi giorni ho rilasciato parecchie interviste. Tra le domande ricorrenti, il primo posto lo merita quella sul rapporto realtà-finzione in Confine di Stato: “Quanto c’è di vero in quello che scrivi?”
Rispondere a questa domanda vuol dire tirare in ballo la poetica del romanzo. E la funzione didattica che ho tentato di imprimergli.
Ho discusso a lungo della cosa nel famoso Dietro le Quinte che il sito Catlerock pubblicherà a giorni.
E non voglio anticipare nulla.
Per cui vedrò di affrontare l’argomento partendo da un altro punto di vista: la presenza di Pete Bondurant nel libro e la visione ellroyana del rapporto realtà-finzione.
Pete B., per chi non lo conoscesse, è uno dei protagonisti degli ultimi due romanzi di James Ellroy (American Tabloid e Sei pezzi da mille). Pete è stato un truffatore, un uomo d’azione, un addestratore di esuli anticastristi, un narcotrafficante e un grandissimo fan di JFK.
Pete è un sopravvissuto. Vuoi perché il buon James tende a sterminare i propri personaggi (da un libro all’altro, sono pochi quelli che sopravvivono. Pete è uno di questi. Ed è vivo per miracolo…).

Vuoi perché la sua visione della Storia è l’unica a reggere fino in fondo.
Pete ha parecchi punti di contatto col mio Sterling. Come mi ha giustamente fatto notare Wu Ming 2, Sterling è una presenza ossessiva nel romanzo. Si occupa in prima persona pressoché di tutto. Piazza le bombe, fa fuori i buoni, stupra, ricatta, stringe mani e fa carriera.
Questa eccessiva sovraesposizione rende il personaggio (volutamente, sia chiaro) bidimensionale.
Un cattivo da film, per l’appunto. Un cattivo troppo cattivo per essere reale.
Pete svolge una funzione simile nei romanzi di Ellroy. Pete tiene duro e sopravvive (infrangendo le regole della prosa ellroyana, che permettono a un personaggio di “abitare” due romanzi solo a patto che nel primo dei due sia solo una presenza fuggevole…) perché è irreale. Perché è troppo presente. Perché è, come Sterling, troppo coinvolto dalla sindrome del faso tuto mì (per dirla col linguaggio del Nord-Est).
Beninteso, io trovo straordinario questo eccesso di protagonismo (tant’è che lo ripropongo pari pari). Specialmente perché diventa la cifra della finzione in un racconto a sfondo reale.
Cataldo Bevilacqua, di Facoltà di Frequenza, mi ha fatto notare come molta gente, dopo i libri di Ellroy, è fermamente convinta che l’affair Kennedy sia andato proprio come dice il vecchio James.
Questo è uno dei rischi di questo mestiere: essere presi troppo sul serio.
Le cose non sono andate come racconta American Tabloid. O almeno non ci sono sufficienti fonti documentarie ad avvalorare tale ipotesi. Ma non importa, perché American Tabloid non è un libro di storia.
È semplicemente (dici poco…) uno dei migliori romanzi del XX secolo.
E personaggi come Pete, nella loro bidimensionalità, nella loro sovraesposizione, sono là a ricordarlo.
Questo discorso è ribaltabile su Confine. Ed ecco perché il cameo di Pete.
Secondo Wu Ming 2 è stato un passo più lungo della gamba. E la verosimiglianza dell’opera ne ha risentito.
Forse è vero e forse no.
Ad ogni modo, nella costruzione di un romanzo come Confine, la verosimiglianza è un problema tangenziale. Secondario.
Nella fattispecie: è verosimile che l’Editore (parlo di quello reale) fosse rintanato a Cuba. È verosimile che i nostri uomini in nero avessero contatti con addestratori di anticastristi cubani attivi Miami (Pete). Per nulla verosimile è l’incursione.
Ma non lo era nemmeno in Ellroy.
Questo ci riporta esattamente dove sarebbe opportuno stare: in una dimensione narrativa a cavallo tra storia e fiction. Dove quasi nulla è vero (anche se sembra verosimile) perché storiograficamente poco dimostrabile.
Ma, se mi posso permettere, anche questo è un falso problema. Perché né io né Ellroy intendevamo scrivere un manuale di storia.
Carlo De Blasio a Tempi Dispari mi ha chiesto se scrivere fiction di un certo tipo possa aiutare la magistratura a sbrogliare le matasse dei Misteri Italiani. Io gli ho risposto di no.
Almeno quando si tratta di fiction come la mia. O quella di Ellroy.
I processi sul caso Montesi, sulla morte di Enrico Mattei e sulla strage di Piazza Fontana sono conclusi. E per questi fatti nessuno è colpevole.
La stessa cosa vale per la
 faccenda JFK.
faccenda JFK.Nel mio romanzo (così come in quelli di Ellroy) i colpevoli ci sono, eccome. E hanno nomi e cognomi.
Ma nulla di ciò che fanno è dimostrabile storicamente.
Dunque: è sterile fare questo genere di fiction? Per nulla. Anzi.
Il tipo di narrativa che faccio (ecco la famosa funzione didattica) ha come sogno recondito quello di spingere il lettore a saperne di più. A documentarsi, a studiare. Magari proprio per venire a confutare la storia che racconto in Confine.
Io ho reagito così ai libri di Ellroy (ma anche a quelli di Evangelisti, di Genna, di De cataldo o dei Wu Ming): ho studiato. Mi sono documentato. E ho finito per fare il stesso mestiere.
Credo che serva a questo la fiction che scriviamo.
A creare miti. A non far dimenticare storie. A ricordare.
Anche se a volte i ricordi trasfigurano il reale. E finiscono per non assomigliargli più.