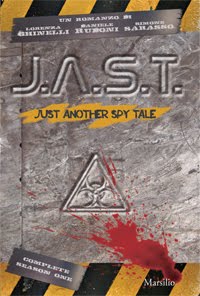Se questo pezzo esiste, la colpa è di una delle mie pessime abitudini: il pisolino.
Lo so che fa vecchia zia in pensione, ma quando non lavoro (a scuola), dopo pranzo non so resistere: il richiamo del divano è troppo forte.
D’altronde (lo dico per darmi un tono) lo dice anche Stephen King che nel lasso di tempo immediatamente post-prandiale si sente come un boa che ha appena inghiottito una gazzella, e la pennica è l’unica possibilità.
Divano e tv, si diceva.
E verso le due la scelta non è ‘sto granchè. Su Italia Uno c’è l’ultimo strascico di Slam Ball e ti viene da seguir l’azione e saltare in piedi sul sofà. Su MTV le biondine in bikini di Laguna Beach e non chiudi occhio neanche a parlarne.
Meglio i cari, vecchi cartoni. Che sia DragonBall o Naruto, cinque minuti cinque e sono già nel mondo dei sogni.
Che poi, se cartoni devono essere, il digitale terrestre che l’hai preso a fare? Che quel signore basso basso e l’amico suo della Lazio hanno fatto una legge apposta.
E dunque: Boing. Ventiquattrore su ventiquattro di anime old school e ricicli Mediaset.
Niente da dire, perfetti per appisolarsi.
Il punto è quando ti svegli.
Ancora nel dormiveglia una musichetta mi catapulta indietro di vent’anni (guardate un po’ se anche a voi fa lo stesso effetto…). E mi ritrovo a pensare a me stesso su un tappeto di pelo arancione nel salotto di casa di mia nonna. A giocare col Lego e bere Estathé.
Ora, col vintage in qualche modo ci campo e ho abbastanza confidenza col passato da non farmi travolgere da facili entusiasmi alla Notte prima degli esami.
Però questo è davvero un colpo basso e non c’è santo che tenga: quando appare il faccino paffuto di Arnold non posso fare a meno di godermi l’intera puntata in religioso silenzio.
Oltretutto sono anche fortunato, perché l’episodio è una chicca. Quello in cui Arnold e il suo amico, in trasferta a Hollywood si perdono negli Universal Studios tentando di infilarsi sul set di Supercar.
C’è pure un ovvio cammeo di David Hasselof e del suo destriero parlante a quattro ruote.
Mi piacerebbe potervi dire che l’emozione mi ha travolto e “com’erano belli i telefilm di una volta, signora mia…”.
Ma racconterei delle balle.
Il tv show risente dell’età, e succedono cose improbabili: KITT parla davvero, anche se la guardia degli Studios chiama Hasseloff per nome e non “Micheal”. Arnold e il suo compare vagano per i teatri di posa deserti e a un certo punto un animatrone dello Squalo li spaventa a morte. E poi finiscono sul set della Famiglia Addams e un simil Lerch li mette in fuga…
Ok, il telefilm è di vent’anni fa. Ma per l’utente attuale la supposta sospensione d’incredulità è veramente troppo. Non la voglio fare troppo semplice, non fraintendetemi. Il telefilm era tutto da ridere e lo spettatore medio (dell’Ohio o di Rozzano, poco importa) non si poneva il problema. Il punto è che queste esagerazioni inquadrano il prodotto per quello che è. Negandogli l’immortalità.
Immortalità che serie come Star Trek o Spazio 1999, pur con le loro mille oscene ingenuità, hanno ottenuto.
La distanza tra le serie di ieri e quelle di oggi è sotto gli occhi di tutti. E non mi sognerei di affiancare nemmeno per un istante Arnold a Lost (ambiti troppo diversi).
Ad ogni modo, pur nello stesso campo da gioco, Arnold troverà un paio di righe in qualche dizionario dei telefilm, FRIENDS rimarrà nella storia.
Come c’è rimasto SUPERCAR.
Ci sono produzioni che diventano immortali. Altre che vanno a ingrassare il bagaglio retrò dell’appassionato di modernariato.
Uno dei fattori principali che influiscono sull’eternità di una serie è, io credo, la continuity.
Vent’anni fa gli show erano studiati per intrattenere a orari fissi con format rigidi, statici. La stessa scenetta che si ripete più o meno in loop puntata dopo puntata. Lo show funziona, ma non evolve.
In serie come Happy Days (cito questa per rimanere nel mainstream, ma potrei citare BlueMoon, la serie che lanciò Bruce Willis), invece, dopo un paio di stagioni, si scelse la linea della continuity, dell’evoluzione dei personaggi (Ricky va in Vietnam, si sposa e mette su famiglia. Chucky e Joanie si innamorano, convolano a giuste nozze e guadagnano anche la dignità di un spin-off, mai andato – credo; l’ho visto solo in inglese – in onda da noi).
Passa di lì la strada che ha portato alla costruzione del serial moderno.
Senza continuity, Lost non sarebbe niente.
Detto questo, arrivo finalmente a Tarantino, che occhieggia dal titolo e che ancora non ha avuto un minuto per dire la sua. E se parli di Tarantino non puoi ignorare il discorso sul vintage.
La Seventies-mania che ha investito il mondo globalizzato negli ultimi dieci anni ha fatto muovere i primi passi verso la riscoperta del nostro recente passato. Un passato essenzialmente pop (e tutto è pronto per il ritorno in pompa magna dei temibili Ottanta).
Il vintage, che negli Eighties era di pessimo gusto, ha recuperato dignità. E il futuro, che nell’ottantacinque scherzavamo a mascelle spalancate, assomiglia davvero a quello rappresentato in capolavori come Rollerball, dove le case del duemila sono piene di modernariato Anni Settanta e per ascoltare la musica si usa uno strano aggeggio rettangolare con una rotella in centro.
Un conto è, però, il recupero della memoria, un conto è il consumo critico.
Vintage sì, ma con jiuicio. Non vale la regola che se una cosa ha venti o trent’anni allora è cool di default.
Viva Bruce Lee, viva l’A-Team. Ma, vi prego, abbasso Arnold e abbasso Automan.
Un discorso simile deve averlo ben chiaro in testa Quentin Tarantino da almeno una quindicina d’anni.
Kill Bill è un capolavoro citazionistico. Mai pesante, ma sopra le righe (anche se, costantemente, oltre ogni riga). È un tributo al passato. Ma con uno sguardo insindacabile al futuro. La direzione in cui Kill Bill guarda è chiara. E il capolavoro di Mr. T. non assomiglia all’angelo della storia di Benjamin (non ha la capoccia storta à rebours).
E lo stesso discorso vale per il maltrattatissimo Grindhouse.
La versione mozzata che è arrivata in Europa presta maggiormente il fianco alle critiche. Le due ore di Kurt Russel che arrota passanti e belle sgnacchere è fuori contesto.
Consiglio agli appassionati di attendere il dvd americano in cui Grindhouse e Planet Terror non sono divisi.
Oppure di scaricarsi la versione originale del double feature col caro vecchio mulo.
Alla fine delle tre ore di spettacolo, la sensazione che rimane in bocca è ben diversa da quella che trasmette la proiezione del surrogato apparso nelle nostre sale.
Le due pellicole, tanto per cominciare, sono collegate (da minuscoli particolari, come accadeva nei nostri film a episodi degli Anni Settanta). E le storie sono buone storie. Con fascino retrò, questo è indubbio, ma modernissime (le ragazze di Grindhouse ascoltano l’ipod e mandano sms).
E queste storie estreme e ultraviolente, come solo Mr. T. sa creare, galleggiano in una cornice supercool, intervallate da finti trailer di finti film d’azione o de paura, da spot gustosamente antiquari che avvisano che il contenuto delle pellicole non è adatto ai più piccini, e altre mille chicche.
E esci dal cinema con la sensazione che i veri grindhouse, quelli di trent’anni fa, non fossero così divertenti (se li riguardi te ne accorgi subito). Così come i film di Bruce Lee erano molto più pallosi di Kill Bill.
Per cui, signore e signori: Vintage sì, ma non troppo.
E soprattutto con gusto e cabeza.